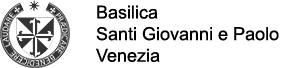Frati > Ordine domenicano > I Domenicani a Venezia
I domenicani a Venezia
di Massimo Mancini O.P *
San Domenico (1170-1221, spagnolo) parlava poco: in base alla testimonianza di un suo contemporaneo, il fondatore dell’Ordine dei Predicatori “parlava o con Dio o di Dio”.
Colui che lo afferma è il primo frate domenicano veneziano: fra Paolo Veneto, compagno di s. Domenico nei viaggi da lui fatti nell’ultimo periodo della sua vita. Proprio fra Paolo è il contemporaneo che ci dà la testimonianza di questo: “dovunque fosse, il maestro parlava sempre o a Dio o di Dio; anzi col suo esempio spingeva noi ad imitarlo, e lo fece includere nella regola dell’ Ordine”.
S. Domenico, Paolo Veneto, S. Martino, SS. Giovanni e Paolo
Fra Paolo da Venezia e fra Frugerio abruzzese, nella loro deposizione nel processo di canonizzazione di s. Domenico, dichiarano che entrarono nell’Ordine nella quaresima del 1219 e precisamente il 3 marzo, nella chiesa della Mascarella, che fu la prima residenza dei Domenicani in Bologna; lo dice esplicitamente fra Paolo.
Dopo il ritorno del santo castigliano a Bologna, nell’agosto del 1219, Paolo e Frugerio diventarono da allora i suoi costanti compagni di viaggio: vissero a contatto quotidiano con Domenico per due anni.
Ecco la deposizione di fra Paolo al processo di canonizzazione di s. Domenico: «Dal giorno che il maestro venne in Bologna, ebbi grande familiarità con lui; ho goduto della sua conversazione per due anni circa, sia nel convento di Bologna, a mensa o in coro, che in accompagnarlo nella Marca Trevigiana. Non uscì mai di sua bocca parola oziosa, di maldicenza, adulatoria o nociva; ed in viaggio lo vidi sempre pregare, predicare o assorto nei misteri di Dio». Interrogato fra Paolo dai giudici di come conoscesse tali cose: «Il maestro, rispose, diceva a me ed ai miei compagni: – Andate avanti e pensiamo al nostro Salvatore; e poi lo sentivo gemere e sospirare».
Proseguendo, Paolo ricorda: «Dovunque fosse, il maestro, parlava sempre o a Dio o di Dio; anzi col suo esempio spingeva noi ad imitarlo, e lo fece includere nella regola dell’Ordine».
Aggiunge: « Non l’ho visto mai turbato, agitato o irato, né nelle fatiche del viaggio né nel dolore; ma lo vidi sempre ilare nelle tribolazioni, paziente nelle avversità ».
Nell’estate del 1221, dopo il capitolo generale di Bologna, Domenico, accompagnato da fra Paolo si diresse a Venezia, dove sapeva trovarsi il cardinale Ugolino (il futuro pontefice Gregorio IX), legato del papa per organizzarvi una crociata.
Qualche studioso ha ipotizzato che il cardinale legato, amico e protettore di S. Domenico, abbia desiderato discutere col santo spagnolo non solo circa il progetto della crociata, ma anche di una presenza stabile di Frati Predicatori in Venezia; ma le fonti antiche non ci dicono nulla in proposito.
Occorre tuttavia notare che Domenico rimase a Venezia anche dopo la partenza del cardinale Ugolino, il 7 luglio; come pure va notata l’assenza di Paolo Veneto da Bologna quando il fondatore vi morì il 6 agosto.
Non abbiamo notizie su una permanenza dei primi Domenicani a Venezia, dopo il viaggio di S. Domenico. Sappiamo però che già cinque anni dopo c’era già una comunità, forse fondata dallo stesso Paolo da Venezia.
Il padre Albasini afferma che i frati domenicani abitarono sotto i portici di S. Martino, a Castello, allo stesso modo che i Francescani sotto i portici di S. Marco. Se ciò appare vero per i Francescani, non sembra così per i Domenicani; non tanto per i diversi ideali dei due Ordini, quanto per il fatto che altrove i Predicatori, appena arrivati in una città, erano accolti negli ospizi o negli ospedali presso le chiese.
Nei documenti si parla di fra Martino priore dei Domenicani della chiesa di S. Martino in Venezia: “ecclesiae Sancti Martini de Venetiis Ordinis Praedicatorum”. Questo significa che la chiesa di S. Martino appartiene ai frati e fa escludere che essi abbiano dimorato sotto i portici. Queste fonti sono: una petizione, firmata dal suddetto priore Martino nell’ottobre 1226, rivolta al vescovo di Padova; ed un diploma autografo del papa Gregorio IX, che nell’aprile 1229 nomina fra Martino visitatore delle diocesi di Cèneda, Feltre, Belluno e Concordia.
Nel giugno del 1234, i Domenicani ottengono una sistemazione definitiva, nel luogo che ancora oggi è da essi occupato. A nome della Repubblica e di tutto il popolo, il doge Jacopo Tiepolo concede a fra Alberico, priore dei frati, un terreno vicino a S. Maria Formosa e a S. Marina; ed il doge giustifica la concessione affermando che la residenza dei Domenicani in città, per il governo e per il popolo tutto, è sommamente necessaria.
Si tratta di un territorio ancora instabile, soggetto al riflusso della marea; ciò può motivare la lunghezza dei tempi di edificazione della chiesa e del convento. C’è una bolla del papa Innocenzo IV, riportata da Flaminio Corner, che nel luglio 1246 concede indulgenze a chi, con elemosine, contribuisca alla costruzione della chiesa: tale documento può far ritenere che in quell’anno l’erezione del nuovo tempio sia ormai vicina al compimento.
II fatto poi che lo stesso Jacopo Tiepolo abbia scelto proprio i SS. Giovanni e Paolo come luogo per la propria sepoltura, dimostra una predilezione per i Domenicani e per la loro nuova chiesa; un’opinione che sarà poi condivisa in seguito da molti altri dogi ed esponenti di rilievo della vita pubblica. Il sepolcro del doge Tiepolo si vede tuttora addossato alla facciata della basilica, a sinistra del portale d’ingresso, guardandolo dal campo.
Da ciò si capisce l’importanza ben presto acquisita dai Frati Predicatori e della loro capacità di penetrare all’interno del mondo veneziano, anche ai massimi livelli: tra l’altro, essi, seguendo una linea di condotta ispirata a motivi fondamentali dell’ideale domenicano, non limitano la propria attività alla sola sfera religiosa, ma partecipano anche in talune occasioni alle vicende politiche della città. Ed essi saranno anche aiutati dal mondo politico, come vedremo dopo. È un mondo in cui i rapporti tra la Chiesa e lo stato, tra l’autorità civile e quella ecclesiastica, sono molto diversi da quelli che noi oggi conosciamo: c’è una compenetrazione, non necessariamente una corruzione, c’è un rapporto stretto di reciproco aiuto, a volte anche di indebita ingerenza, come si direbbe oggi, da una parte e dall’altra.
Già nel Duecento entrano a far parte della comunità dei SS. Giovanni e Paolo uomini rimasti celebri per la loro santità e anche per gli incarichi ricevuti: soprattutto nel 1248 il veneziano beato Giacomo Salomoni, morto a Forlì nel 1314 (i cui resti sono ora nella nostra basilica veneziana), e nel 1254 il beato trevigiano Niccolò Boccasini, poi maestro di tutto l’Ordine e infine pontefice (1303-04) col nome di Benedetto XI.
Si costruisce la chiesa e si edifica un grande convento, destinato ad ospitare numerosi religiosi: si può ritenere che alla fine del Duecento il complesso conventuale sia ormai compiuto.
Riforma di fine Trecento: S. Domenico di Castello e altri conventi, Giovanni Dominici, Caffarini
Nel Trecento viene costituita anche un’altra comunità domenicana nella città di Venezia, con i fondi messi a disposizione, per testamento, dal doge Marino Zorzi, nel giugno 1312: la chiesa ed il convento di S. Domenico di Castello. Nel 1317 essi sono già completati e sottoposti alla giurisdizione del priore dei SS. Giovanni e Paolo (il convento principale) che allora è Tommaso Loredan.
Dov’era S. Domenico di Castello? Nell’attuale via Garibaldi, a Castello, dove ora è l’ingresso dei giardini pubblici. Napoleone Bonaparte nel 1807 volle demolire completamente chiesa e convento di S. Domenico: rimane ora solo un portale gotico di una pertinenza del convento, ed il nome della calle S. Domenico. Non rimane niente di una comunità che fu molto importante per secoli.
E poi, ancora nel Trecento, a Murano (allora in diocesi di Torcello) sorge un altro convento per volontà e con il denaro di Marco Michiel (+1349). Dal 1363 inizia la costruzione del convento e della chiesa, che viene consacrata nel 1417: S. Pietro Martire. Per fortuna, questa chiesa ancora esiste, risparmiata dalla furia delle soppressioni ottocentesche.
Le comunità veneziane dei Predicatori subiscono nella seconda metà del Trecento una crisi, che è un fenomeno di portata generale, presente anche negli altri Ordini religiosi: dopo la peste nera del 1348, problemi di vario tipo, qui causati anche dalla guerra di Chioggia, provocano la decadenza della vita religiosa. Ma proprio qui ha inizio il grande movimento di riforma di tutto l’Ordine domenicano: Venezia ne è il centro propulsore. La storia dei Domenicani a Venezia è importante per tutto l’Ordine, perché da qui parte la prima riforma domenicana.
S. Caterina da Siena, la grande “mantellata” domenicana, è la maestra di numerosi discepoli, fra i quali il beato Raimondo delle Vigne, o Raimondo da Capua, che è anche il suo primo biografo e che viene eletto maestro dell’Ordine nel 1380, obbediente al papa Urbano VI al tempo della Chiesa bicefala, quando vi sono insieme due papi, e presto saranno tre: un periodo tragico della storia della Chiesa. Raimondo è il grande animatore della riforma domenicana.
Che cosa è la riforma? Il ritorno alla forma originaria dell’Ordine, secondo lo spirito iniziale, quello di s. Domenico; perché nel frattempo c’è stato un rilassamento.
Il primo convento che espressamente, per volontà dei suoi membri, realizza la riforma, è quello di Colmar in Alsazia, ora in territorio francese, ma all’epoca in area tedesca. Ma subito dopo la riforma inizia e si sviluppa proprio qui a Venezia. Altri discepoli di Caterina arrivano qui e dànno inizio ad una rinascita dell’Ordine domenicano, che avrà effetti ovunque.
Proprio nel tempo del grande scisma, c’è la rinascita del nostro Ordine, soprattutto ad opera del beato Giovanni Dominici, che poi sarà cardinale (+1418) e protagonista al concilio di Costanza. Fiorentino, ma anche di origini veneziane, perché la madre è Paola Zorzi, veneziana. Verrà creato cardinale da un papa veneziano, Gregorio XII (Angelo Correr), che lo ha conosciuto qui a Venezia.
Nel 1388 Raimondo da Capua nomina Giovanni Dominici lettore ai SS. Giovanni e Paolo (il lettore è colui che è incaricato di dare lezioni di teologia e di filosofia ai frati e anche agli estranei), che poi viene designato vicario presso il medesimo convento. Questa città non era estranea per il frate toscano, dato che durante la giovinezza, prima di entrare fra i Predicatori, egli vi aveva trascorso due anni dopo la morte del padre, per volontà della madre, appartenente ad una delle più antiche famiglie veneziane.
E proprio la presenza di Giovanni Dominici, tenace assertore dell’osservanza domenicana, dà inizio alla riforma.
L’introduzione dell’osservanza regolare nella comunità di S. Domenico di Castello, che le fonti ci descrivono come desolata e in piena decadenza (pur essendo il convento più recente), fu attuata dal frate toscano poco dopo, tra la fine del 1391 ed i primi mesi del 1392: il convento, rinnovato dal¬l’afflusso di un gruppo di religiosi provenienti da diverse province del¬l’Ordine, viene reso indipendente da quello dei SS. Giovanni e Paolo e ha un proprio priore per la prima volta, che ha il bel nome di fra Tommaso Aiutamicristo da Pisa.
Il numero dei se¬guaci della riforma domenicana cresce molto presto, in modo tale che, nello stesso 1392, è possibile estenderla al convento di S. Domenico di Chioggia dove, in un edificio in gran parte abbattuto all’epoca della guerra contro i Genovesi, erano rimasti appena due frati, privi di ogni cosa. Dopo un breve viaggio dove fonda un altro convento riformato a Città di Castello, nella provincia Ro¬mana, il Dominici riprende ad occuparsi decisamente delle fondazioni ve¬neziane: dalla comunità di S. Domenico di Castello egli fa passare ai SS. Giovanni e Paolo dodici confratelli, i quali rinnovano la vita domenicana anche all’interno del cenobio più antico. L’operazione riesce così bene da fare scegliere nel 1394 il convento riformato dei SS. Giovanni e Paolo quale sede di un capitolo generale di tutto l’Ordine, il secondo a Venezia dopo uno già celebratovi nel Duecento. Uno speciale stanziamento di fondi da parte della Repubblica a favore dei Domenicani viene ap¬provato dal Maggior Consiglio proprio per sovvenzionare le spese di ospitalità per i numerosi frati giunti qui per quell’importante assemblea.
Un punto importante, caratteristico della nostra storia, e che riguarda tutte le riforme domenicane: mentre i Francescani e gli altri Ordini, quando operano la riforma, cioè il ritorno all’antica osservanza, normalmente si separano, si dividono e nascono nuovi Ordini, per noi Domenicani questo non è mai accaduto. L’Ordine dei Predicatori è sempre rimasto unito. Gli osservanti potevano fare la riforma con strutture autonome, ma sempre unite e obbedienti al maestro dell’Ordine, successore di s. Domenico, al quale tutti noi Domenicani, anche oggi, facciamo la nostra professione di obbedienza. La professiamo al maestro di tutto l’Ordine: questo unifica tutti noi Domenicani, sparsi nel mondo.
Nel giugno 1394 viene inaugurato il monastero femminile domenicano del Corpus Christi, che già esisteva, come comunità benedettina, dal 1375, ma ora viene ricostituito, sem¬pre su ispirazione del Dominici, passando dalla regola di s. Benedetto a quella agostiniana, secondo le costituzioni dei Predicatori, come già si era fatto a S. Domenico di Pisa dalla beata Chiara Gambacorti.
Fra parentesi, la prima fondazione di s. Domenico non è quella dei frati, ma quella delle monache: nella Francia meridionale, a Prouilhe. C’è una presenza femminile domenicana fin dall’inizio, prima ancora delle comunità maschili; essa si diffonde poi con esperienze molto significative, nei diversi secoli e nelle differenti realtà geografiche. Ma qui, nei limiti di questa trattazione, purtroppo non è possibile descrivere la storia veneziana delle donne appartenenti al nostro Ordine.
Occorre almeno ricordare il motivo che porta Giovanni Dominici a lasciare Venezia: la grande processione del movimento dei cosiddetti Bianchi (o Battuti, o Disciplinanti), avvenuta nel 1399; questi movimenti si spargono per l’Europa in un momento difficilissimo per tutta la Chiesa. Il governo veneziano non vuole assembramenti sospetti. Ma una massa di penitenti arriva a Chioggia nel settembre 1399 ed il Consiglio dei Dieci prescrive al podestà del luogo di adoperarsi affinchè i penitenti rimangano lon¬tani da Venezia. Nonostante l’opposizione del governo, che teme conseguenze politiche da quest’afflusso di Disciplinanti che si battono chiedendo misericordia a Dio, si tiene ugualmente una processione in città, il 18 novembre 1399, animata da Giovanni Dominici. La processione viene dispersa con la violenza proprio nel campo dei SS. Giovanni e Paolo. Tre giorni dopo viene decretata la condanna dei principali organiz¬zatori: il Dominici è condannato a cinque anni di bando dall’intero territorio veneziano. E anche altri vengono puniti, tra cui il nobile veneziano Antonio Soranzo, dell’Ordine domenicano della Penitenza (una specie di terziario). Infatti in quegli anni si sviluppa anche il Terz’Ordine domenicano, chiamato Ordine della Penitenza: laici che, continuando a vivere nelle proprie case e svolgendo le loro attività, vivono un’appartenenza spirituale al nostro Ordine.
Altro importante protagonista del nuovo movimento di riforma domenicana a Venezia è Tommaso da Siena, più noto come Tommaso Caffarini: il grande promotore del processo di canonizzazione di s. Caterina da Siena. Tale processo si svolge qui a Venezia, anche se Caterina qui non c’è mai stata.
È detto “processo castellano”, dal vescovo di Castello, Francesco Bembo, davanti al quale ha inizio la causa. Come si sa, non c’era ancora il patriarca: il primo sarà s. Lorenzo Giustiniani nel 1451. Caffarini è l’attore della causa ed è testimone. Il processo che si conclude nel 1416 ma la canonizzazione sarà nel 1461.
Da questa base di conventi osservanti in Venezia, la riforma si estende, gradualmente, in tutte le province dell’Ordine domenicano. Si formano delle congregazioni riformate di osservanza, sempre unite e obbedienti al maestro di tutto l’Ordine, che via via arrivano ad inglobare un sempre maggior numero di conventi e di religiosi. Questo avviene sempre più nel Quattrocento e nel Cinquecento. S. Domenico di Castello rimane legato alla congregazione riformata di Lombardia che comprende più tardi anche il convento di Bologna. È la congregazione dove entra Girolamo Savonarola, che poi darà origine ad un’altra congregazione riformata, quella di S. Marco di Firenze.
Qui a Venezia c’è una predicazione capillare, con grande frequenza di pubblico, non solo nelle chiese domenicane, ma anche altrove. Vi sono contatti a tutti i livelli, con tutti i ceti sociali: importanti sono le confessioni e quelle che oggi chiamiamo direzioni spirituali: ministeri caratteristici del nostro Ordine.
Ai SS. Giovanni e Paolo ancora nel 1487 c’è un grande capitolo generale del nostro Ordine. Le cronache parlano di lusso e sfarzo; ovviamente c’è il finanziamento da parte di famiglie del patriziato veneziano e anche dal governo veneto. Viene eletto maestro dell’Ordine proprio il veneziano Gioacchino Torriani (1487-99): colui che poi darà il suo consenso alla condanna di Savonarola e presenzierà a Firenze alla sua esecuzione.
L’enorme basilica dei SS. Giovanni e Paolo, adornata con le opere di grandi artisti, sempre più diventa il Pantheon veneziano, con le tombe di molti dogi e di altri illustri personaggi: e i funerali dei dogi si svolgono ordinariamente proprio in quella grande basilica.
Tra Quattrocento e Cinquecento numerose sono le figure che dànno prestigio alla presenza dei Domenicani in Venezia. Qui ne segnalo solo qualcuna: il beato Agostino da Biella (+1493); Alberto da Castello (+1522), autore di un’importante opera sul Rosario; due frati che poi diventano patriarchi di Venezia, Tommaso Donà (+1504) e Girolamo Querini (+1554); Tommaso de Vio (detto il Gaetano), affiliato al convento dei SS. Giovanni e Paolo, grande teologo, originale commentatore delle opere di s. Tommaso e avversario di Lutero, maestro di tutto l’Ordine (1508-18), poi cardinale (+1535).
Nel corso dei decenni, però, quell’energia spirituale che ha caratterizzato i nostri conventi veneziani finisce con l’affievolirsi gradualmente: come purtroppo accade quasi sempre nelle cose umane, ciò vale anche per quelle dei religiosi. Nel secolo XVI, sempre più la società veneziana avverte il bisogno di un ritorno dei Domenicani alla precedente osservanza; e ciò si vede anche in occasione della fondazione di una nuova comunità domenicana.
È una presenza che temo ormai dimenticata: si trovava sull’isoletta di S. Secondo, oggi vicina al ponte della ferrovia, a destra andando verso Mestre, ormai completamente abbandonata e piena di alberi e cespugli. Per secoli fu sede di una chiesa e di un convento dei Domenicani. Prima ancora, dal Medio Evo aveva ospitato una comunità di monache benedettine che, a causa della loro vita rilassata, vengono trasferite nel 1529 alla Giudecca per ordine del papa Clemente VII, mentre il loro monastero viene soppresso. Nel 1535 il senato veneziano, tornato proprietario dell’isola, la affida ai Domenicani, ed essi, nella persona del padre Zaccaria da Luni, vicario del maestro dell’Ordine, lo ricevono “con espressione, che in esso si vivesse secondo la Regola di S. Agostino, e tenore delle nostre Sante Constituzioni”, come ricorda il padre Sterni in un manoscritto seicentesco. Deve quindi essere un convento di osservanza.
Sulla piccola isola vi è posto solo per la chiesa con il convento e le sue pertinenze; nessun altro insediamento, ecclesiastico o laico, è possibile in uno spazio così ristretto.
Dapprima, per favorire l’osservanza, il convento è assegnato non alle province domenicane dell’Italia settentrionale, ma alla provincia Romana; esso rimane poi sotto l’immediata giurisdizione del maestro dell’Ordine fino al 1641, quando il maestro Ridolfi decide di attribuire S. Secondo alla nuova provincia di S. Domenico di Venezia.
Questo fatto mi dà modo di fare cenno ad una modifica istituzionale, avvenuta nel frattempo. Vi dicevo che l’Ordine si suddivide in province, che raggruppano un certo numero di conventi e di frati su un certo territorio: per esempio, attualmente, qui abbiamo la provincia dell’Italia settentrionale, che si chiama provincia di S. Domenico in Italia.
Nel secolo XVI, riguardo all’ambiente veneziano, la situazione era invece questa: convento di S. Domenico di Castello, alla provincia di Lombardia, erede della congregazione riformata; convento di S. Secondo, alla provincia Romana ma sotto il maestro dell’Ordine; convento dei SS. Giovanni e Paolo, che dal 1580 è la sede principale della nuova provincia di S. Domenico di Venezia, che comprende diversi conventi, sparsi sul territorio della Repubblica Veneta.
S. Domenico di Castello, per la verità sempre meno osservante, va avanti fino all’età napoleonica come parte della provincia lombarda, che riunisce molti conventi di Emilia, Lombardia, Marche e Liguria: il più importante è quello di Bologna. Anche S. Pietro Martire di Murano appartiene a questa provincia. Dal 1560, il tribunale veneziano dell’inquisizione romana, dapprima affidato ai Francescani, viene attribuito ai Domenicani del convento di Castello, uno dei quali sarà l’inquisitore di Venezia fino allo spegnersi dell’inquisizione a fine Settecento.
Fra i vari membri della comunità di Castello c’è anche un papa: Vincenzo Maria Orsini, che entra nel nostro Ordine a S. Domenico di Castello nel 1668 e che poi diventerà nel 1724 il papa Benedetto XIII (+1730), il quarto e finora ultimo pontefice appartenente all’Ordine dei Predicatori.
Il cenobio dei SS. Giovanni e Paolo rimane sempre quello con il maggior numero di religiosi: un centro di studi con una bellissima biblioteca. Nel 1782 esso accoglierà come ospite il papa Pio VI, nella trionfale tappa veneziana del suo viaggio per incontrare Giuseppe II a Vienna.
Seconda riforma: Pica, la congregazione del Beato Giacomo Salomoni, il convento delle Zattere, D. Còncina
La realtà più interessante della presenza domenicana a Venezia tra Seicento e Settecento è però un’altra: quella della congregazione osservante del Beato Giacomo Salomoni. Ho già fatto cenno al beato veneziano a cui è intitolata.
Nel 1662 il maestro dell’Ordine domenicano Giovanni Battista de Marinis istituisce un’altra congregazione domenicana di osservanza: questa è la seconda riforma dell’Ordine, almeno qui a Venezia e nel territorio veneto, dopo la prima del beato Giovanni Dominici e di altri protagonisti. La nuova congregazione è inserita all’interno della già esistente provincia domenicana di S. Domenico di Venezia. Per incrementare l’osservanza delle leggi e dello spirito dei Domenicani, si segue così l’antico metodo già usato 250 anni prima: senza mai scindere l’Ordine, i frati e i conventi che desiderano essere più fedeli all’antico ideale di s. Domenico vengono costituiti in congregazioni autonome.
Questo nuovo insieme di conventi e di frati, legati fra loro dall’obbedienza ad un vicario generale scelto dal maestro di tutto l’Ordine, ha stile di vita regolare garantito da apposite norme giuridiche; e tali comunità, inizialmente, fanno capo al convento di S. Secondo, che dal 1660 è passato al vero regime di osservanza.
Come nasce la seconda riforma domenicana veneta? Si ispira al Concilio di Trento, dall’osservanza abruzzese di Paolino Bernardini, che si riallaccia a Girolamo Savonarola e, mediante lui, ancora al Dominici e a Raimondo da Capua; andando a ritroso nei secoli, si vede una continuità storica fra le due riforme. Attraverso l’udinese padre Giorgio De Longis, formatosi nei conventi abruzzesi riformati dal Bernardini e poi tornato in patria, la riforma arriva nei periferici conventi del Friuli.
Così, mentre la prima riforma trecentesca, si può dire, è nata nella città di Venezia e poi si è diffusa in tutto l’Ordine, la seconda inizia in terraferma, nelle terre agli estremi confini della Repubblica Veneta, anzitutto al convento di Cividale del Friuli. Ma a Venezia avrà la sua affermazione definitiva ed il suo pieno sviluppo, con qualche più limitato riflesso in altri territori.
Questa riforma, come la prima, vuole applicare integralmente le costituzioni dei Frati Predicatori: ovviamente, se si insiste su questo dato, ciò significa che nei conventi non riformati le leggi domenicane non si applicavano integralmente. C’erano dispense, cioè deroghe, alle norme; c’era una vita troppo rilassata. Gli uomini sono deboli e hanno continuamente bisogno di riformarsi; si dice infatti: Ecclesia semper reformanda. La Chiesa stessa, nei suoi uomini, deve riformarsi, secondo il Vangelo: tutti noi cristiani abbiamo da riformarci, e questo vale anche per gli Ordini religiosi.
Questo movimento di osservanza domenicana si caratterizza per l’attenzione alla povertà della vita religiosa, alla preghiera comunitaria e allo spirito di penitenza. Non manca mai l’interesse per lo studio, che è un dato scontato per noi Domenicani; l’apostolato della predicazione non è mai trascurato, anche se, leggendo i documenti dell’epoca, la sottolineatura riguarda soprattutto lo stile di vita all’interno del convento.
Si dà molto rilievo agli aspetti forse più formali ed esteriori dell’osservanza, dai digiuni rigorosi alle vesti tradizionali, che debbono essere sempre di lana, anche se nel Seicento la lana è molto più costosa rispetto a quattro secoli prima; ma ciò risponde alla sensibilità dell’uomo dell’età barocca, sempre molto attento all’esteriorità.
Uomini importanti fanno parte di questa seconda riforma veneta. Dopo De Longis, il padre Bernardino Gosellino, priore provinciale della provincia di S. Domenico di Venezia. Nonostante questo incarico, egli non riesce ancora a stabilire un regime di osservanza nella provincia: malgrado i suoi tentativi, ai SS. Giovanni e Paolo la seconda riforma non verrà mai accolta, per l’opposizione dei religiosi dimoranti in quel convento.
È un napoletano trapiantato in Friuli, il padre Basilio Pica, colui che finalmente riesce a far uscire la nuova riforma dal ristretto ambito dell’area friulana (Friuli veneziano e Friuli austriaco, cioè la zona di Gorizia): nel 1660 il convento di S. Secondo di Venezia passa all’osservanza regolare. Ma questo riformatore napoletano non sarebbe mai riuscito a introdurre la riforma a S. Secondo, se non avesse goduto del pieno appoggio della classe politica.
Il governo della Repubblica era normalmente interessato ad avere sul proprio territorio dei conventi di osservanza e noi delle comunità rilassate. I religiosi erano infatti chiamati a contribuire all’affermazione del potere della Repubblica: nel 1660 erano passati pochi decenni dal tempo di fra Paolo Sarpi, dei Servi di Maria, che in qualche modo si era fatto anche strumento della politica della Serenissima verso la Santa Sede, all’inizio del Seicento. Cinquant’anni più tardi, non c’è più quella contrapposizione tra la Repubblica e il papato, però i religiosi dei diversi Ordini sono ancora considerati titolari di una funzione pubblica nella società civile. D’altronde, si dice che in tutta l’Europa cattolica il Seicento è il secolo dei conventi: luoghi in cui anche i laici andavano e si intrattenevano per conversare e discutere; così i religiosi di tutti gli Ordini avevano una grande influenza nella società. In tale contesto, il governo veneziano aveva tutto l’interesse ad avere conventi (anche domenicani) non rilassati, ma di osservanza.
Nel 1660 si è ormai formata quella che oggi si potrebbe chiamare una lobby politica: quella dei sostenitori della riforma domenicana (contro i Domenicani non osservanti). Fra di loro sono uomini di grande rilevanza, a cominciare dal doge Domenico Contarini. È proprio il doge ad imporre al provinciale domenicano di rimuovere il priore di S. Secondo perché questi è contrario all’osservanza, vuole mangiare la carne quando l’antica regola la proibirebbe e sostiene uno stile di vita più rilassato e meno povero. Questo priore, il padre Salvetti, secondo il doge deve essere rimosso; e alla fine viene costretto a dimettersi. C’è tutto un ambiente politico, anche nel senato veneto, che spinge perché a S. Secondo venga realizzata la riforma domenicana; e l’operazione riesce.
D’altra parte, in una visione ancora propria del regime di cristianità, è lo stesso concilio di Trento a ordinare alle autorità civili, in virtù di santa obbedienza, di sostenere l’azione dei riformatori della vita religiosa, in modo generalizzato. Questo è il clima dell’epoca: ed il governo può farsi forte perfino delle prescrizioni del concilio per affermare la necessità di applicare l’autentica osservanza domenicana.
Nella storia della riforma veneta, è decisivo il passaggio del convento di S. Secondo all’effettiva osservanza nel 1660; finalmente la riforma coinvolge la città Dominante, e non più solo la terraferma ai confini dello stato; e questo le assicura l’appoggio di importanti personalità della società veneziana, che garantiscono protezione giuridica, favore politico e risorse economiche agli osservanti.
Si tutelano giuridicamente i frati e i conventi di osservanza; poi si crea una congregazione che li riunisce, mentre nuovi conventi si aggiungono ai preesistenti e si erige un centro di studi accademici.
Le principali figure di riferimento, intorno alle quali si coagulano forze diverse, sono due. Uno, come si è visto, è Basilio Pica, l’uomo che sa mettere insieme i religiosi e le autorità politiche, le garanzie giuridiche e l’austerità della vita. L’altro è un frate veneziano, Girolamo Piccini, degno discepolo del Pica, il continuatore non inferiore al suo maestro: Piccini è colui che ingrandisce e rende più robuste le strutture della congregazione appena fondata nel 1662. Altri conventi in terraferma si aggiungono poi a quelli che già formano dall’inizio la congregazione.
Pochi anni dopo, nel 1669, si costituisce un nuovo convento alle Zattere, laddove era presente l’Ordine dei Gesuati, appena soppresso dal papa Clemente IX. I locali già occupati dai Gesuati vengono messi all’asta e, con l’aiuto di benefattori facoltosi, i Domenicani osservanti (quindi non quelli dei SS. Giovanni e Paolo) acquistano la chiesa e l’ex-convento dei Gesuati alle Zattere.
Inizialmente, essi occupano la chiesa rinascimentale dei Gesuati, la più piccola che ancora vi si trova, con il convento non molto grande. Questa nuova comunità domenicana, nel corso dei decenni, accoglie un sempre maggior numero di frati, perché ospita uno studio, anzi un collegio, nel senso di un centro di studi istituzionali di filosofia e di teologia, dove i Domenicani sono professori; ad esso giungono studenti che non sono solo i membri del nostro Ordine, ma sono anche preti secolari e perfino laici: essi vengono al convento e ascoltano le lezioni tenute dai docenti domenicani.
I fedeli affluiscono alle celebrazioni dei frati e alle confessioni in numero sempre maggiore; all’inizio del Settecento la chiesa rinascimentale ed il piccolo convento che furono dei Gesuati sono evidentemente insufficienti per i Domenicani osservanti. Essi decidono perciò di costruire una nuova chiesa, operazione che dura per decenni. Raccolgono offerte in tutta la città per molti anni: dalle corporazioni, dalle scuole, da soggetti privati.
Ce lo testimonia un interessante manoscritto, conservato nell’archivio domenicano di Bologna, redatto dal padre Carlo Lazzaroni: il frate che per decenni percorre Venezia chiedendo denaro per la costruzione della nuova grande chiesa.
Nasce così quel capolavoro del tardo barocco che è la chiesa del Rosario, dove lavorano grandi maestri come il Massari, il Tiepolo, il Piazzetta ed altri ancora. Le opere d’arte che il nuovo tempio contiene sono il segno di una sapienza condivisa dai religiosi della comunità e trasmessa da una generazione all’altra. Sono testimonianze ammirate anche dai cittadini e dai forestieri, che vedono in questa comunità qualcosa di diverso e di migliore rispetto a molte altre presenze di religiosi nella città lagunare.
La chiesa viene dedicata alla Madonna del Rosario: si vuole così ricordare il rosario, un modo di pregare che è molto caro ai Domenicani, anche se non risale al fondatore s. Domenico, come talvolta si dice erroneamente. Dal Quattrocento in avanti, i Domenicani hanno lavorato molto per diffondere questa preghiera.
La chiesa delle Zattere non può correttamente essere chiamata “dei Gesuati”, perché i Gesuati avevano soltanto la chiesa più piccola, rinascimentale. Oltre cinquant’anni dopo la sparizione dei Gesuati, i Domenicani iniziano a costruire la chiesa di S. Maria del Rosario, ristrutturando e ampliando notevolmente il convento. Quindi la denominazione di chiesa dei Gesuati, che purtroppo è quella più comune, è storicamente un errore, è proprio sbagliata. La grande chiesa tardo-barocca del Rosario alle Zattere non è mai stata dei Gesuati; è nata domenicana, è la chiesa dei Domenicani. Ed il programma iconografico della chiesa più grande è completamente domenicano: tutto, nel tempio progettato dal Massari, ci parla dell’Ordine domenicano.
Alla fine del Seicento le autorità statali chiedono il contributo dei Domenicani riformati anche nelle colonie venete nel lontano Levante: cioè il Peloponneso (o Morea) e le isole Ionie. Alcuni frati saranno uccisi dai Turchi a Nauplia nel 1715, quando le truppe ottomane invaderanno le colonie veneziane della Morea; altri verranno imprigionati e fatti schiavi.
In patria, molti frati conquistano la fiducia dei deboli come dei potenti, mediante la predicazione e il ministero delle confessioni; altri, primo fra tutti Bonifacio Grandi, si dedicano all’insegnamento e alla scrittura, diventando maestri di numerosi giovani.
Per più di un secolo, il convento delle Zattere a Venezia è un centro di spiritualità e di cultura la cui importanza valica i confini della Serenissima.
Il collegio del Rosario ospita una grande biblioteca, arricchita con migliaia di libri donati nel 1750 ai frati dal letterato Apostolo Zeno, amico ed estimatore dei religiosi delle Zattere. La biblioteca viene perciò detta Zeniana: essa, con la soppressione napoleonica confluirà nella biblioteca Marciana.
Uomini di grande spessore umano e religioso, come Fulgenzio Cuniliat, Bernardo de Rubeis, Daniello Còncina, Gianvincenzo Patuzzi ed altri ancora, dànno grande lustro alla congregazione del Beato Salomoni con la predicazione, l’insegnamento e la pubblicazione di libri.
De Rubeis pubblica nel 1751 un’importante storia della congregazione veneta di osservanza: una miniera di notizie per gli storici.
I frati delle Zattere, primo fra tutti Daniello Còncina, esercitano un influsso non solo nell’ambiente veneziano, ma anche a Roma e in tutta Italia. La loro produzione teologica suscita interesse ovunque; ma dà origine anche ad aspre polemiche su vari temi, specialmente in contrasto con i Gesuiti. Còncina è un grande predicatore, teologo, autore di libri e di polemiche che incendiano il dibattito teologico e politico a metà Settecento.
Di fronte al lassismo di molti Gesuiti, i Domenicani delle Zattere (non quelli dei SS. Giovanni e Paolo) si scagliano contro la dottrina del probabilismo in campo morale, fino ad essere accusati a loro volta di rigorismo.
Le polemiche coinvolgono anche aspetti politici. Nel 1747 i Gesuiti diffondono, a carico dei Domenicani riformati, una falsa accusa di tradimento a danno della Repubblica. È un incidente internazionale che vede sotto accusa Daniello Còncina, autore di libri contro il lassismo gesuitico, ed anche il de Rubeis.
Durante la guerra di successione austriaca, si fa circolare la notizia di un investimento ingente dei Domenicani a Genova, con il denaro raccolto per edificare la chiesa delle Zattere. La repubblica di Genova è in guerra contro l’Austria, quindi i frati del Rosario sono accusati di aver finanziato uno stato in conflitto contro il potente vicino austriaco, mettendo in pericolo la neutralità veneziana.
Il padre Lazzaroni, andando per la città a chiedere offerte per la chiesa e il convento, rischia di essere gettato in un canale dalla gente che lo insulta. Poi organizza dei collaboratori inviandoli in caffè, botteghe e sacrestie per attuare una controinformazione favorevole ai Domenicani. Il governo veneto ordina indagini presso Genova ed altre piazze finanziarie, ma è proprio così che l’autorità statale arriva a scagionare i frati delle Zattere: non c’è stato alcun investimento all’estero. I Domenicani alla fine evitano un’ingiusta espulsione dallo stato veneto. All’epoca gli scontri teologici fra gli Ordini religiosi potevano anche avere conseguenze politiche ad altissimo livello.
Soppressioni e ripresa
Il Settecento è un periodo molto fiorente per i Domenicani veneziani della congregazione di osservanza; ma questo sviluppo termina quasi all’improvviso con le soppressioni statali degli Ordini religiosi. Già la politica ecclesiastica dello stato veneziano, comincia ad attuare dal 1768 alcune parziali soppressioni di conventi e a rendere difficile la comunicazione con i superiori a Roma. Uno dei primi conventi soppressi è quello di Pellestrina (diocesi di Chioggia), che i Domenicani riformati avevano ottenuto nel 1735.
Napoleone Bonaparte porta a compimento la cancellazione di ogni forma di vita religiosa: egli spazza via non solo la Repubblica, ma anche, nell’arco di alcuni anni, i conventi dei Domenicani e di tutti gli altri Ordini religiosi. Con l’annessione di Venezia al napoleonico Regno d’Italia, si arriva nel 1810 alla totale soppressione delle comunità religiose. S. Secondo era già stato soppresso qualche anno prima; S. Domenico di Castello, come già detto, viene completamente raso al suolo per realizzare i giardini pubblici; i frati vengono tutti concentrati alle Zattere e ai SS. Giovanni e Paolo, ma nel 1810 vengono chiusi anche questi ultimi due conventi e i religiosi vengono dispersi: ciascuno deve trovarsi un’abitazione in qualche luogo. La vita domenicana sembra definitivamente sparita dalla scena, insieme a quella degli altri Ordini.
Ma c’è una ripresa inaspettata, dovuta all’ultimo frate rimasto ai SS. Giovanni e Paolo, il padre Emanuele Lodi. I Domenicani non si erano mai occupati di parrocchie, perché questo non è mai stato un apostolato caratteristico del nostro Ordine; ma, di fatto, la parrocchia diventa un modo per far sopravvivere la presenza domenicana a Venezia. Infatti l’ultimo frate prende l’incarico di parroco della nuova, parrocchia dei SS. Giovanni e Paolo, appena costituita per volontà del governo napoleonico nello stesso 1810: si mantiene così una presenza di un frate, seppure senza l’abito domenicano. Più tardi il padre Lodi diventerà vescovo di Udine.
La restaurazione austriaca presenta i lenti, difficili tentativi di ripristino, che approdano nel 1843, anche per volontà del patriarca Monico, alla fondazione di una nuova, piccola comunità a S. Lorenzo: sono i pochi frati rimasti della congregazione del Beato Giacomo Salomoni a ricostituirsi come comunità presso la chiesa che era stata delle monache benedettine. Si vorrebbe così riprendere il percorso della gloriosa congregazione delle Zattere, ma il piccolo convento ha in realtà un’esistenza stentata. Dopo pochi anni la comunità di S. Lorenzo passa alla provincia di Lombardia, che ha il suo centro a Bologna.
Nel frattempo mutano le condizioni politiche: si firma un concordato fra Austria e Santa Sede e i frati possono ricostituire una piccola comunità anche ai SS. Giovanni e Paolo, anch’essa appartenente alla provincia lombarda. Questa più antica sede domenicana ospita ormai i frati non più nel grande convento, adibito ad ospedale fin dal periodo napoleonico, ma in un piccolo edificio sul luogo della scuola di S. Orsola, privata degli splendidi teleri del Carpaccio e poi abbattuta.
Nel 1866, al momento in cui Venezia passa dall’Austria al nuovo Regno d’Italia, c’è a Venezia una significativa presenza domenicana a S. Lorenzo, sede del nuovo noviziato provinciale di Lombardia, ed una più piccola ai SS. Giovanni e Paolo.
L’ultimo, effimero sviluppo del convento di S. Lorenzo termina quasi subito, con i provvedimenti a danno dei religiosi, applicati dal nuovo stato italiano a partire dal 1866; nuove difficoltà poste dallo stato impediscono il reclutamento delle vocazioni. I religiosi domenicani lasceranno definitivamente S. Lorenzo nel 1881.
Rimane quindi solo il convento dei SS. Giovanni e Paolo, con la parrocchia amministrata dai Domenicani: una presenza di religiosi numericamente piccola, ma non trascurabile dal punto di vista qualitativo. Nel Novecento c’è anzitutto una figura importante: un parroco santo. È il Venerabile padre Giocondo Lorgna (+1928), parroco per molti anni ai SS. Giovanni e Paolo e fondatore delle suore domenicane della Beata Imelda, che hanno la loro scuola accanto alla chiesa dei Miracoli. La causa della sua beatificazione è molto ben avviata.
Che cosa rimane oggi della presenza domenicana a Venezia? Una comunità di frati ai SS. Giovanni e Paolo, non numerosa ma rinnovata e ringiovanita negli ultimi anni, con l’attività parrocchiale e con il Centro culturale S. Tommaso d’Aquino, da poco costituito, che organizza conferenze e concerti. Come sempre, per il nostro Ordine è importantissima la cosiddetta pastorale della cultura: noi dobbiamo aiutare lo sviluppo culturale del nostro prossimo, nella società di oggi.
Questa è la situazione attuale, ma i Domenicani che ora sono a Venezia sono gli eredi di una tradizione ricchissima. Io ho cercato di riassumerla, senza purtroppo approfondire molti aspetti importanti; ma credo sia stato comunque importante e utile aver ripercorso così un capitolo non irrilevante della storia veneziana e una parte importante della storia dell’Ordine domenicano.
Bibliografia essenziale
C. ALBASINI, San Domenico e i suoi a Venezia, Venezia 1922.
A. BARZAZI, Gli affanni dell’erudizione. Studi e organizzazione culturale degli ordini religiosi a Venezia tra Sei e Settecento, Venezia 2004.
E. BOAGA, voce Soppressioni. IV, in Dizionario degli Istituti di Perfezione, VIII, Roma 1988, 1811-1817.
G. CAPPELLETTI, Storia della Chiesa di Venezia dalla sua fondazione sino ai nostri giorni, Venezia 1855.
F. CORNER, Notizie storiche delle chiese e monasteri di Venezia e di Torcello, Padova 1758, (rist. anast. Bologna 1990).
A. D’AMATO, L’Ordine dei Frati Predicatori, Roma 1983.
B.M. DE RUBEIS, De rebus Congregationis sub titulo Beati Jacobi Salomonii in Provincia S. Dominici Venetiarum erectae Ordinis Praedicatorum commentarius historicus, Venetiis 1751.
M. FOIS, voce Osservanza, Congregazioni di osservanza, in Dizionario degli Istituti di Perfezione, VI, Roma 1980, 1036-1057.
V. FOLLI, Il Convento di S. Domenico in Venezia e il B. Giovanni Dominici, in Memorie Domenicane 39(1922), 183-195.
W. HINNEBUSCH, I domenicani. Breve storia dell’Ordine (trad. it. di The Dominicans, New York s.d.), Cinisello Balsamo 1992.
A. NIERO, Tre artisti per un tempio. Santa Maria del Rosario – Gesuati – Venezia, Venezia 2006.
E. SASTRE SANTOS, La vita religiosa nella storia della Chiesa e della società, Milano 1997.
F. SORELLI, La santità imitabile. “Leggenda di Maria da Venezia” di Tommaso da Siena, Venezia 1984.
I. TAURISANO, I Domenicani in Venezia, Venezia 1922.
F. ZAVA BOCCAZZI, La basilica dei Santi Giovanni e Paolo in Venezia, Venezia 1965.
*Trascrizione parziale della conferenza per le Scuole Grandi
Venezia, Scuola Grande di S. Teodoro, 14 maggio 2009
Massimo Mancini o.p. è professore di Storia della Chiesa nella Pontificia Università S. Tommaso (Angelicum) di Roma e nella Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna di Bologna.