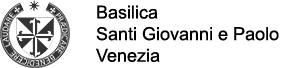Home > Storia della basilica
Una notte il doge Jacopo Tiepolo († 1242) vide in sogno l’oratorio di S. Daniele e l’acquitrinosa zona circostante, piena di meravigliosi fiori sui quali volavano bianche colombe con una croce d’oro in fronte; ad un tratto due angeli scesero dal cielo con turiboli spargenti soavi profumi e s’udì una voce: “Questo è il luogo che scelsi per i miei Predicatori“. Il giorno dopo il doge raccontò la visione al Senato ed ottenne l’appoggio per dotare di un convento i Domenicani che, presenti a Venezia già da oltre un decennio, abitavano ancora sotto i portici di S. Martino (?).
Storia o leggenda?
Realtà o artificio di Jacopo Tiepolo che giudicò la permanenza dei Domenicani utilissima a Venezia, tanto da affermare: “eorumque moram in civitate Venetiarum nobis et toti populo pernecessariam existimantes?“. Comunque sia, l’atto di donazione venne firmato nel 1234; ed il munifico dono è ricordato sulla tomba del doge: “Omnia praesentis donavit praedia templi” (2° tomba da sinistra sulla facciata).
Il Tempio fu dedicato, forse per volere del doge stesso, ai due Santi fratelli Giovanni e Paolo (Zanipolo per i veneziani) martiri a Roma nel IV secolo. La chiesa ducentesca, della quale sembra rimanga solo la parte inferiore della facciata, fu presto finita. Ma l’importanza del tempio, subito scelto a sepoltura da molti dogi, e lo sviluppo sempre crescente dell’azione dei frati Domenicani, imposero un ampliamento. All’inizio del XIV secolo fu intrapresa la costruzione delle solenni arcate; l’opera diretta dai Domenicani Fra Benvenuto da Bologna e Fra Nicolò da Imola (costruttori delle chiese di S. Agostino a Padova, oggi distrutta, e di S. Nicolò a Treviso) venne portata a termine nel 1368, come testimonia una iscrizione posta nella prima arcata di sinistra presso l’organo.
All’inizio del secolo furono nominati Procuratori della fabbrica di S. Zanipolo alcuni patrizi veneziani per assicurare l’ultimazione ed un continuo abbellimento del tempio. In fine, a quasi due secoli dalla fondazione, il 14 novembre 1430, la chiesa fu consacrata dal domenicano Antonio Correr, Vescovo di Ceneda, nobile veneziano e nipote di papa Gregorio XII. Nel 1437 fu trasferita da S. Croce presso l’attiguo convento la Scuola Grande di S. Marco, che otteneva di compiere le sue funzioni religiose nella cappella absidale maggiore. Se consideriamo che sulla pietra che serra i dodici costoloni delle volte è scolpito il Leone di S. Marco col libro, scudo di detta Scuola Grande, e che lo stile di questa cappella absidale lo si trova in altre chiese della seconda metà del ‘400, si può affermare che tale parte sia stata rifatta o ultimata dai Signori della Scuola (Gino Fogolari: “Frari e i SS. Giovanni e Paolo”, Milano 1949).
Pantheon dei Dogi
Giovanni Hammer nella sua “Storia dell’Impero Ottomano” chiama S. Zanipolo “Pantheon dei Dogi“. E poiché attorno alle grandi figure dei suoi dogi sorse, si sviluppò e si mantenne sempre la grandezza della Serenissima, S. Zanipolo si può ben definire sintesi delle glorie veneziane. Già alla fine del Duecento quattro dogi (il donatore Jacopo Tiepolo, Renier Zen, Lorenzo Tiepolo e Giovanni Dandolo) avevano qui trovato la loro sepoltura gloriosa. E così fu anche in seguito: solo nel sec. XV su 14 dogi, ben otto furono qui sepolti. Infine, dopo la metà del ‘400, la Signoria decretò che i funerali solenni di tutti i dogi si tenessero in S. Zanipolo, anche se fossero stati poi tumulati altrove. Nel 1682, per meglio svolgere queste imponenti manifestazioni ufficiali, il coro, racchiuso (come ai Frari) fra le prime quattro colonne della navata centrale, venne demolito e in parte trasportato nel presbiterio.
I munumenti presenti in Basilica
Ogni monumento di questo tempio narra una pagina della secolare e gloriosa storia veneziana, della sua potenza e delle sue vittorie. Il monumento a Vittor Pisani (cappella absidale della Maddalena) ricorda il trionfo sulla grande rivale genovese nella decisiva battaglia di Chioggia (1380). Davanti alla cappella del Nome di Gesù, sotto una lastra marmorea, riposa quell’Alvise Diedo che riportò in salvo da Costantinopoli la flotta veneziana rinchiusa da Maometto nella rada (1453). La pelle dell’eroe veneziano per antonomasia, Marcantonio Bragadin, qui conservata in un’urna, ci ricorda l’assedio e la cadu¬ta di Famagosta (1571); mentre la grande battaglia di Lepanto, dello stesso anno, è commemorata nel mirabile monumento ufficiale della Signoria: la cappella della Madonna del Rosario, alla cui entrata, sul lato destro, riposano le spoglie mortali del vincitore, Sebastiano Venier.
La secolare lotta con l’irriducibile nemico turco fu conclusa il 26 Giugno 1656 (giorno dei SS. Giovanni e Paolo) quando Lazzaro Mocenigo, annientata la flotta nemica, penetrò nello stretto dei Dardanelli trovandovi, con la vittoria, gloriosa morte: ciò è ricordato nel grandioso mausoleo della famiglia di Bertucci Valier, doge al tempo della battaglia. Ma la minaccia forse più grave della sua storia, Venezia l’ebbe dalla lega di Cambrai (1508); e dall’abside maggiore il grande doge Leonardo Loredan ancora si protende per far scudo a Venezia col suo corpo contro il mortale pericolo. Nicolò Orsini, conte di Pitigliano, Leonardo da Prato e Dionigi Nando di Brisighella, capitani delle fanterie veneziane contro gli alleati di Cambrai, hanno qui i loro monumenti. Ed ancora i monumenti ad Orazio Baglioni e a Pompeo Giustiniani, caduti nel passaggio dell’Isonzo e sul Carso, fanno rivivere alla memoria la lotta contro l’Austria per la difesa del retro¬terra dalmata e giuliano.
Genova, i Turchi, la lega di Cambrai, l’Austria: le tappe dell’epopea veneziana sono immortalate nelle loro fasi decisive del genio artistico veneziano in S. Zanipolo, sul cui frontale a ragione si potrebbe porre la frase che Napoleone volle a S. Genoveffa di Parigi: “Aux grand Hommes la Patrie recon-naissante”.
> Basilica Interno
> Pittura
> Scultura